-
Categoria principale: RIVISTA online HELIOPOLIS
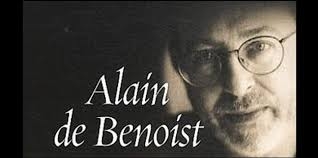
INTERVISTA a
ALAIN DE BENOIST
a cura
di Giovanni Sessa
(pubblicata su Antarès n° 2 del 2012)
D. La crisi che sta investendo, ormai da tempo, l’Occidente è assai profonda e incisiva. Essa non riguarda solo l’ambito economico, ma anche gli assetti politici e geo-politici indotti dall’esito devastante del secondo conflitto mondiale. Può indicare ai nostri lettori, in sintesi, le cause che l’hanno prodotta e gli scenari che essa potrebbe aprire?
- R. La nozione di crisi è il paradigma della nostra epoca. Oggi è particolarmente evidente nei domini economici e finanziari, ma lei ha ragione a dire che riguarda in realtà tutti gli ambiti. La crisi è associata all'incertezza che nasce dall'azzeramento dei sistemi di riferimento. Sul piano delle relazioni internazionali e della geopolitica, l'incertezza proviene dal crollo del sistema sovietico, che ha posto fine al «Nomos della Terra» (Carl Schmitt) del dopoguerra. A seguito degli accordi di Yalta, vivevamo in un sistema binario, americano-sovietico. Il mondo si divideva sommariamente tra un «blocco dell'Est» e un «mondo libero» posto sotto la tutela degli Stati Uniti d'America, e queste due potenze si affrontavano indirettamente, dietro alla contrapposizione di taluni paesi del Terzo Mondo. All'indomani della caduta del Muro di Berlino, gli Stati Uniti hanno creduto di potersi istituire come unica potenza dominante e dare vita a un mondo unipolare. Era l'epoca in cui i neoconservatori sognavano un «nuovo secolo americano». Questo sogno non è sopravvissuto né alle difficoltà interne degli Stati Uniti, né agli insuccessi militari dell'Iraq e dell'Afghanistan e nemmeno all'esaurimento di un sistema finanziario internazionale fondato sull'egemonia del dollaro. La storia, della quale Francis Fukuyama aveva imprudentemente annunciato la «fine», ha rapidamente fatto ritorno. L'incremento della potenza dei paesi «emergenti» (Cina, India, Brasile, ecc.) ha fatto sentire i suoi effetti, nel momento in cui la Russia ritrovava gran parte della sua potenza. Al giorno d'oggi possiamo solo speculare sul nuovo «Nomos della Terra» che si sta affermando, ma è evidente che ci dirigiamo verso un mondo multipolare (un multiversum e non un universum), nel quale i grandi blocchi continentali di civiltà e civilizzazione sono chiamati a giocare il ruolo di regolatori del processo di globalizzazione. Al contempo, la geopolitica ritrova i suoi diritti. Il vecchio conflitto tra la potenza del Mare (ieri l'Inghilterra, oggi gli Stati Uniti) e della Terra (ieri la Germania e la Russia, oggi il continente euroasiatico) ha riacquistato attualità. Per gli studiosi di geopolitica, l'Eurasia costituisce l'«isola mondiale» (world island), vale a dire il centro della terra. Zbigniew Brzezinski lo ripete nel suo libro The Grand Chessboard: «Chi controlla l'Eurasia controlla il mondo». Gli Stati Uniti cercano di balcanizzare il Medio Oriente, di «accerchiare» la Cina e la Russia, di impedire all'Europa di emanciparsi dall'alleanza transatlantica. È emerso un nuovo «arco di crisi», che va dalla Mesopotamia sino all'Afghanistan. Grazie alla sua posizione geopolitica, l'Iran è al centro di questo gioco di influenze – e nulla esclude ormai che una nuova guerra, le cui ripercussioni e conseguenze saranno imprevedibili, possa essere intrapresa contro di esso. Potremmo dire, riassumendo, che il momento storico nel quale viviamo è una fase di Zwischenheit, un interregno. Tutti gli interregni suscitano malessere: mentre ogni potenza cerca di massimizzare le proprie posizioni, ancora nulla si sa dell'esito di quei movimenti che si dispiegano sotto i nostri occhi. Si ridistribuiscono le carte. È, beninteso, questa assenza di limpidezza dell'avvenire ad alimentare le crisi. In momenti del genere, gli strumenti concettuali di cui disponiamo diventano parimenti obsoleti: non sono più funzionali ad analizzare gli accadimenti. Da qui la necessità di prestare attenzione a quel che va profilandosi. Non dimentichiamo, infine, che un fenomeno analogo si osserva perfino all'interno delle società sviluppate, nelle quali la modernità a poco a poco cede il posto alla postmodernità. La scomparsa dei sistemi di riferimento si fa evidente anche nella vita quotidiana. Le vecchie generazioni non riescono più a comunicare con le nuove, le parole alle quali le prime facevano riferimento hanno perso il loro senso. È un mondo nuovo che sta apparendo. Ciò che oggi chiamiamo «crisi» potrebbe perfino corrispondere ad una «rivoluzione» silenziosa senza pari, almeno dall'epoca della rivoluzione neolitica.
- D. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla progressiva crisi di rappresentatività delle democrazie liberali. Su di esse si stende sempre più evidente l’ombra della governance, i popoli vengono espropriati del loro diritto alla decisione politica. Gli ultimi casi di Grecia e Italia sembrano confermarlo, in modo addirittura teatrale. Lei ritiene ancora valido il richiamo, sviluppato nel suo libro Democrazia il problema (Arnaud, Firenze 1985), alla “democrazia organica”, quale unico antidoto a questa situazione? Per quale ragione?
R. Ciò che chiamiamo «crisi di rappresentatività» non è che l'aspetto di un fenomeno più ampio, che si riassume nella frattura sempre più grande che ormai separa la massa dei cittadini da una classe politica nella quale questi non si riconoscono più. Un fenomeno che è particolarmente impressionante nelle forze di «sinistra», nella misura in cui in passato queste si sono sempre definite quali rappresentanti e portavoce del popolo. Questo non si riconosce più nei partiti di sinistra per una serie di ragioni che sono state spiegate da Jean-Claude Michéa nel suo ultimo libro, Le complexe d'Orphée. Abbracciando dapprima l'ideologia del progresso, che tende a scagliare il suo anatema sul passato, poi i valori popolari (a partire dalla common decency di cui parlava il grande George Orwell), allineandosi alla logica del profitto e alla società del mercato, sostituendo la cultura di massa alla cultura popolare, i partiti di sinistra hanno a loro volta tradito i principi fondatori del socialismo e deluso i loro partigiani. Invece di fare autocritica, questa sinistra ha denunciato come «populisti» i tentativi del popolo di riprendere parola. Meglio ancora, si è scelta un popolo di ricambio scommettendo sugli immigrati senza vedere che questi ultimi costituiscono anzitutto le truppe di rincalzo del capitale e che sono soprattutto le classi popolari a soffrire di quelle patologie sociali generate da un'immigrazione massiva. Al contempo, si è propagato il nuovo ideale della governance. Questa nozione, la cui origine appartiene al mondo economico (corporate governance), si fonda sull'assunto secondo cui la politica è qualcosa di troppo complesso per essere lasciato al popolo: i principi della «buona gouvernance» devono essere definiti da esperti, principalmente in termini di efficacia e reddito. Non è più l'economia a dover essere messa a servizio dell'uomo ma quest'ultimo ad adattarsi alle esigenze dell'economia, agli assiomi dell'interesse e alla logica del profitto. Nella misura in cui considera le frontiere come inesistenti, la governance conduce i popoli ad un corto circuito. I casi della Grecia e dell'Italia, ma anche della Spagna, sono in effetti piuttosto eloquenti: i paesi del Sud dell'Europa sono ora governati da tecnocrati e banchieri, le cui politiche di «austerità» giungono a far pagare ai ceti medi e popolari le conseguenze di una crisi di cui essi sono i primi responsabili. La stessa costruzione dell'Europa si è avvalsa, dopo decenni, del medesimo rifiuto a che i popoli siano consultati e associati alle decisioni. Per qualificare questa evoluzione, non è esagerato parlare di una trasformazione in profondità della stessa natura della democrazia. È proprio la sovranità del popolo che è rimessa in discussione. Ed è anche la ragione per la quale credo si debba ritornare a ciò che è realmente la democrazia, ossia un regime che permetta la partecipazione dell'insieme dei cittadini agli affari pubblici. Nel mio studio contestuale avevo già sottolineato l'importanza di questa nozione di partecipazione, che non può ridursi a quella elettorale. In una democrazia, i cittadini non sono solo elettori, ma anche attori. Si può parlare qui di «democrazia organica», di «democrazia diretta» o ancora di «democrazia di base». In ogni caso si tratta di opporre i benefici della democrazia partecipativa ad una meramente rappresentativa, che oggi non rappresenta più nulla. Jean Jacques Rousseau e Carl Schmitt qui si ricongiungono: più c'è rappresentanza in un sistema politico e meno esso è democratico. Una autentica democrazia organica, il cui precursore fu Johannes Althusius, si fonda sul principio di sussidiarietà, detto anche di competenza sufficiente, che consiste nel fare in modo che i cittadini, a tutti i livelli, si occupino personalmente, il più possibile, dei problemi che li riguardano. D'altro canto, in un mondo sempre più globalizzato, anche la democrazia organica è necessariamente una democrazia locale. Si tratta dunque di rilocalizzare la vita politica, ma anche economica, per ridare un nuovo impulso alla medesima nozione di cittadinanza, trovando un rimedio allo sfaldamento sociale e, contemporaneamente, al ripiegamento individualista nella sola sfera privata. - D. Lei, nei suoi saggi, ha spesso fatto riferimento alla “colonizzazione dell’immaginario” contemporaneo, a prevalente connotazione utilitaristico-consumista, operata dai mezzi di comunicazione di massa. La cultura antimoderna, nelle sue diverse declinazioni (Evola, Jünger, Sombart, etc.), può rappresentare ancora un valido antidoto, almeno in questo senso, alla devastazione del mundus imaginalis?
R. La colonizzazione dell'immaginario simbolico ad opera dell'utilitarismo e del «commercialismo» ambientale è in effetti un'altra delle grandi caratteristiche del nostro tempo. Occorre vedervi l'esito logico dell'espansione planetaria di una ideologia liberale che, nella sua stessa essenza, spinge alla sottomissione della politica all'economia. Da questo punto di vista, solo a torto si considera il capitalismo liberale come un mero sistema economico. Esso è invece portatore di una implicita antropologia, che si fonda sul modello dell'Homo oeconomicus, vale a dire su di un uomo esclusivamente produttore e consumatore, che si suppone non abbia come scopo della propria esistenza altro che la massimizzazione del proprio interesse personale. Questa concezione implica a sua volta l'idea, già sviluppata da Adam Smith ma soprattutto da Mandeville nella sua Favola delle api, che i comportamenti egoisti concorrano, inconsapevolmente, al benessere comune. Deriva direttamente da ciò l'idea che il mercato, se libero da intralci, regoli e allo stesso tempo si auto-regoli. Ci troviamo innanzi a una concezione dell'uomo ma anche della morale che si trova fondamentalmente in rottura con i valori predominanti nelle società tradizionali (si veda, in proposito, la critica aristotelica alla crematistica). Ma è anche un'asserzione regolarmente smentita dai fatti: l'attuale crisi finanziaria – che è una crisi strutturale, sistemica e non semplicemente congiunturale – è la prova che il mercato non è minimamente autoregolato e che, se portati all'eccesso, i «mercati liberi» e la «concorrenza pura e perfetta» non sono che meri punti di vista. Quanto al capitalismo liberale, lungi dall'essere in grado di imporsi dei limiti, la sua stessa essenza risiede nella negazione della nozione di limite. Come aveva ben visto Marx, tutto quello che impedisce l'estensione perpetua del mercato non può che essere percepito da quest'ultimo come un ostacolo da sopprimere. Le dinamiche del capitalismo si fondano sulla parola d'ordine «sempre di più!». Questa illimitazione fondamentale del processo di accumulazione del capitale raggiunge ciò che Heidegger scrisse a proposito del Ge-stell, il movimento generale di ispezione del mondo. Storicamente considerata, la cultura «antimoderna» ha rappresentato una reazione salutare contro questa sommersione delle menti operata dai soli valori umanitaristi e mercantilisti. Gli autori di cui lei parla, ma anche molti altri, hanno contestato con forza l'idea secondo la quale l'uomo si ridurrebbe alla sua sola dimensione economica. A mio parere, tuttavia, questa critica ha incontrato rapidamente i suoi limiti. Troppo spesso è stata legata ad autori ostili all'economia – in Julius Evola, questa avversione è pressoché caricaturale – che sfortunatamente ignoravano quasi interamente questo ambito. Denunciavano il «materialismo» delle idee economiche, vedendovi la realizzazione del «regno della quantità», nell'incapacità tuttavia di fare un'analisi seria delle nozioni di mercato, concorrenza, libero scambio, plus-valore, ecc. Essi non nutrivano alcuna simpatia per il sistema capitalista ma erano incapaci di smontarne le fondamenta. Questo spiega il fatto che, presso questi ambienti, raramente vi sono state proposte alternative valide in maniera economica. La tendenza era invece il credere che, essendo l'economia un dominio subalterno, non fosse il caso di curarsene. È un atteggiamento che lasciava evidentemente via libera a coloro che se ne occupavano, anche se in modo contestabile. Paradossalmente, a parte qualche eccezione (da Othmar Spann e Georges Valois fino a François Perroux o Maurice Allais), l'economia è diventata così il «vicolo cieco» di coloro che la criticavano. Una tendenza ancora più marcata presso coloro che immaginavano, decisamente a torto, che i domini economico e sociale fossero in fondo la stessa cosa. Da questo punto di vista, sono decisamente ostile agli equivoci arroganti lanciati da Evola contro tutto ciò in cui ebbe a rilevare del sociale e del popolare. Infine, la critica «antimoderna» si è troppo spesso sviluppata in un'ottica passatista e puramente «restaurazionista»: ci si accontentava di dire che «era meglio prima», senza occuparsi oltremisura di sapere ciò che conveniva fare di fronte agli imperativi del presente e alle sfide dell'avvenire. Frequentare gli autori «antimoderni» è dunque una buona cosa, ma non è sufficiente allorché si cerchi di superare il semplice conforto intellettuale. - D. Il suo iter politico e filosofico è stato lungo e complesso, sempre però connotato dalla centralità dell’approccio metapolitico. Ciò l’ha portata a cogliere l’inanità delle contrapposizioni destra/sinistra, moderno/antimoderno, attorno alle quali ancora si attarda spesso la “battaglia delle idee”. Può spiegare ai nostri lettori, in breve, la necessità teorico/pratica della costruzione della cultura delle Nuove Sintesi?
R. La nozione di metapolitica è stata spesso fraintesa. Certuni vi hanno visto, a torto, un altro modo di fare politica ma in realtà la metapolitica designa un approccio di ordine teorico o intellettuale che considera tutti i domini della conoscenza e del sapere, scienze politiche incluse. Essa implica dunque una certa presa di distanza rispetto alla «politica politicante» di tutti i giorni. È questa presa di distanza che porta a constatare, per esempio, che oggi il divario tra destra e sinistra tende a perdere qualsiasi significato. Una tale contrapposizione permane nel linguaggio corrente sotto l'influenza del gioco parlamentare e della politica istituzionale, ma nel momento in cui si cerca di chiarirne il senso esatto, si finisce sempre di più in un vicolo cieco. Già da un punto di vista storico vi sono sempre state non una destra e una sinistra, al singolare, ma delle destre e delle sinistre, al plurale. I politologi si sono spesso domandati se tutte queste destre e queste sinistre potessero essere ridotte ad un denominatore comune ma non sono mai pervenuti a identificarlo. Prova ne è che certe destre hanno potuto avere una maggiore affinità con certe sinistre che con altre destre, e viceversa talune sinistre più consonanze con certe destre che con altre sinistre. Spesso si fa risalire il divario tra destra e sinistra all'epoca della Rivoluzione Francese. In realtà, è soltanto a partire dalla fine del XIX secolo che questi due termini hanno invaso la mentalità pubblica: non sarebbe mai venuto in mente a Karl Marx, per fare un esempio, di definirsi «uomo di sinistra»! Durante tutto il XX secolo abbiamo visto prodursi un po' dappertutto delle contrapposizioni tra destra e sinistra, ma queste hanno avuto caratteristiche molto differenti a seconda dei periodi e dei paesi. Non si dimentichi, infine, che le parole «sinistra» e «destra» sono state impiegate sempre più frequentemente nei paesi latini piuttosto che in quelli anglosassoni, dove invece si è preferito riferirsi alla dicotomia fra conservatori e liberali, repubblicani e democratici, ecc. In un'ottica metapolitica non ci si preoccupa di sapere qual è l'origine di un'idea in termini di topologia politica. Si trova addirittura piuttosto ridicolo il fatto che uomini «di destra» difendano idee «di destra» per il solo fatto di crederle «di destra», al pari di certi uomini «di sinistra» che parteggiano per idee «di sinistra» per il solo motivo di crederle «di sinistra». Personalmente, ciò che mi interessa di un'idea non è sapere se sia «di destra» o «di sinistra», quanto piuttosto il suo essere giusta o sbagliata. È evidente che è in questo modo che possiamo giungere naturalmente a costruire una cultura ordinata a delle «nuove sintesi». Ma non è che una questione di metodo intellettuale. Uno dei tratti che mostrano che stiamo entrando in una nuova epoca – o in nuovo mondo – è che tutti i grandi avvenimenti politici e storico-sociali di questi ultimi anni hanno rivelato nuove fratture. La costruzione dell'Europa ha generato «pro-europei» e «anti-europei», di destra come di sinistra. Le guerre condotte contro la ex-Jugoslavia, l'Iraq, l'Afghanistan ecc., hanno conosciuto partigiani e avversari tanto di destra quanto di sinistra. Potremmo citare ulteriori esempi di tale sorta, atti a mostrare che le nuove divisioni che stanno apparendo vedono opporsi non più destra e sinistra ma, ad esempio, federalisti e «sovranisti», «globalisti» e «localisti», ecologisti e anti-ecologisti, atlantisti e anti-atlantisti, partigiani e avversari della società del mercato, ecc. La maggior parte delle opere che affollano le librerie vanno del resto già al di là della contrapposizione destra-sinistra – dettaglio, questo, assai significativo. - D. A suo parere vi sono differenze rilevanti tra moderno e postmoderno? Quali? Non è forse necessario, come Lei ha suggerito, per capire la condizione attuale del mondo, tentare di integrare Marx con l’ “antimoderno” Heidegger? Perché?
R. La nozione di modernità è essenziale rispettivamente per gli storici, i sociologi o gli specialisti di storia delle idee. Essa è caratterizzata dall'ascesa e l'espansione della classe borghese, il sorgere della tecnoscienza, l'apparizione degli Stati nazionali, l'irruzione dei valori individualisti ed egalitari, ecc. Tuttavia, si tratta di un'epoca che si confonde anche con il fenomeno, d'altra parte essenziale, della secolarizzazione. Quest'ultimo deve essere interpretato in maniera dialettica. La secolarizzazione non è semplicemente il momento in cui le società politiche si emancipano dalla tutela delle autorità religiose. Al contrario, nella misura in cui ha luogo questa emancipazione, tali società non fanno che tradurre le antiche tematiche di ordine teologico e religioso nel linguaggio delle ideologie profane. L'assolutismo politico è una continuazione della onnipotenza divina; allo stesso tempo, gli storicismi moderni, primo fra tutti l'ideologia del progresso, conferiscono nuovi contenuti a quella concezione lineare della storia avente origine nel monoteismo biblico: la fine della storia rimpiazza il «paradiso», il «benessere» si sostituisce alla salute, l'avvenire prende il posto dell'aldilà, ecc. La fine della modernità coincide più o meno con la caduta del muro di Berlino, con il tracollo del sistema sovietico e la globalizzazione, resa possibile da questo. Ma, beninteso, non è possibile datare con precisione l'emergenza della post-modernità, la cui realizzazione si è effettuata progressivamente. Taluni elementi della modernità perdurano anche in seno alla post-modernità: l'individualizzazione dei comportamenti, il regno della metafisica della soggettività, l'universalismo dei «diritti dell'uomo», il primato dei valori mercantilistici, ecc. Allo stesso tempo, tuttavia, vi appaiono tratti incontestabilmente nuovi. L'individualismo si coniuga all'apparizione di nuove «tribù» (Michel Maffesoli). Si assiste ad uno straordinario sviluppo del fenomeno dei reticoli, siano essi di natura finanziaria o sociale. Tramite internet, l'impegno politico perde totalmente il carattere «sacerdotale» che poteva avere nel XX secolo, all'epoca delle «grandi narrazioni» ideologiche. I progetti collettivi non mobilitano più le folle. Lo Stato nazionale, grande modello politico della modernità, entra definitivamente in crisi. Cessa di essere produttore di forme sociali e, a poco a poco, diviene impotente: risulta troppo grande per rispondere alle aspettative quotidiane delle genti e, al contempo, troppo piccolo per fronteggiare le sfide più importanti del mondo attuale. Il locale (le comunità) e il continentale (i grandi aggregati di civiltà e civilizzazione) rimpiazzano in misura sempre maggiore lo Stato nazionale. La società, perdendo mano a mano i suoi sistemi di riferimento, diventa sempre più «liquida» (Zygmunt Bauman): si deterritorializza, diventa una faccenda di flussi e riflussi. La stessa globalizzazione tende ad abolire lo spazio (le frontiere non arrestano più nulla) e il tempo (tutti gli avvenimenti hanno ormai luogo «in tempo reale»), ecc. Certo, si tratta di una descrizione piuttosto sbrigativa. Ma ciò che è importante vedere è che, mentre si caratterizza per tutta una serie di innovazioni peculiari, il post-moderno dispone anche di un versante che lo ricollega al pre-moderno. Con la fine della modernità certi elementi della cultura pre-moderna, talune forme sociali di tipo «feudale», fanno ritorno sotto nuove spoglie. Senza ombra di dubbio, è proprio per questa ragione che può essere utile rileggere all'occorrenza Marx e Heidegger, a patto che si resti attenti al momento storico in cui ci troviamo a vivere, procedimento che d'altronde corrisponde a tutti gli effetti all'idea di nuove sintesi. - D. La sua è stata definita una “filosofia dell’originario”, strutturata attorno all’idea sferica di tempo e storia, alla luce della quale l’origine non è semplice inizio, ma il sempre possibile. Ciò è particolarmente evidente in una sua opera da poco ripubblicata in Italia, Come si può essere pagani? (Settimo Sigillo, Roma 2011). Quali le differenze tra questa sua posizione e quella tipicamente antimoderna e/o tradizionalista?
R. Ciò che ho scritto a proposito in Come si può essere pagani? è il risultato di un esame della differenza che contrappone la concezione giudaico-cristiana della temporalità e la concezione caratterizzante l'antichità europea. Per gli antichi Greci il tempo aveva struttura ciclica. Gli stessi avvenimenti ritornavano eternamente, senza inizio né fine assoluti (nihil novi sub sole), ma senza che questo «eterno ritorno» si risolvesse nella pura ripetizione, poiché la concezione ciclica delle cose non è incompatibile con il carattere essenzialmente storico dell'esistenza umana. Nella Bibbia, al contrario, la struttura del tempo assume una forma radicalmente nuova. Da una parte, la teologia giudaico-cristiana pone una distinzione tra l'essere creato e l'essere increato: il mondo non è sempre esistito ma è il prodotto di un atto creatore, liberamente voluto da Dio. Dall'altra, secondo l'interpretazione cristiana del mito del peccato originale, l'ingresso nella storia è percepito come conseguenza di una colpa primigenia (il cattivo uso del libero arbitrio che si presume il primo uomo abbia fatto). Questa colpa fa parte di una decadenza che ha condannato l'uomo a condurre un'esistenza storica. Pertanto, troviamo al contempo una forte dimensione storicistica all'interno del monoteismo, poiché il Dio unico si rivela storicamente, come è noto, attraverso la storia del popolo ebraico che con lui ha stretto alleanza. Infine, la storia umana è concepita sotto forma lineare e vettoriale: corredata di un inizio e di una fine assoluti, si suppone che essa conduca in modo unitario la famiglia dell'umanità in una direzione necessaria, all'occorrenza la fine dei tempi, il Giudizio finale, la Parusia, ecc. Questa necessità storica, che pone il divenire storico sotto la tutela della teologia, è stata formulata con una insistenza assai peculiare da Sant'Agostino, prima di essere ripresa dall'ideologia del progresso. Come opposizione alla concezione lineare del tempo, la mia simpatia va evidentemente a quella ciclica degli Antichi. Ciononostante, preferisco ad essa una concezione «sferica», per come notoriamente la si ritrova nella filosofia di Nietzsche («La ruota dell'essere gira eternamente»), anche se oggi come oggi non mi definirei più come un «nietzschiano» di stretta osservanza! Se vi si riflette bene sopra, in effetti, la concezione ciclica della temporalità non rompe ancora del tutto con quella lineare. Ciò con cui essa rompe è l'idea che questa linea abbia un inizio o una fine assoluti. Nella concezione ciclica, la linea prende la forma di un cerchio, ma conserva con quella lineare l'idea di una certa necessità storica. Un autore come Julius Evola, ad esempio, crede alla successione necessaria delle stesse tappe di ciascun ciclo, successione che lo conduce ad identificare l'epoca moderna all'età del Kali-yuga. Evola si accontenta dunque di interpretare nei termini di un declino sempre più accentuato tutto ciò che le ideologie moderne interpretano, al contrario, in termini di progresso, il che può condurre ad un certo tipo di fatalismo. Da parte mia, credo che la storia sia fondamentalmente aperta, essendo per definizione il dominio dell'imprevisto. Credo anche che la distinzione tradizionale tra passato, presente e futuro sia piuttosto equivoca, e in certa misura artificiale. In realtà, il passato e l'avvenire non sono «momenti» distinti dal presente, quanto piuttosto dimensioni presenti in ogni attimo. Se vi si riflette un istante, tutto ciò che è accaduto «nel passato» è avvenuto in un momento nel quale esso altro non era che presente. Lo stesso dicasi per tutto ciò che accadrà «nell'avvenire». Nella concezione sferica della storia, non è che tutto sia possibile in qualsiasi momento. Vi sono anche, con tutta evidenza, processi di lunga durata che devono giungere al loro termine per compiersi. Ma è legittimo rivolgersi al passato, non per cercarvi rifugio, o per attingervi una consolazione in qualche modo nostalgica, quanto piuttosto per trovare in esso esempi da rendere poi attuali nel proprio momento storico. Nietzsche diceva, e a ragione, che «non si ritorna ai Greci». Heidegger, a sua volta, propone di fare come i Greci, ma in modo ancora «più greco», il che vuol dire volgersi al momento aurorale, inaugurale, del «cominciamento greco», ma al fine di scoprire le condizioni per un nuovo cominciamento. - D. Il suo pensiero, proprio sulla scorta di questa idea di storia come apertura inesausta, si proietta verso il futuro ed è, in qualche modo, una “filosofia della speranza”. Per questo, conclusivamente, Le chiedo: di fronte alla situazione attuale, che speranze è possibile nutrire?
R. Personalmente, non parlerei di «speranza». Questa idea è decisamente ottimista; ora, credo che le cose qui non si pongano in termini di ottimismo o pessimismo. È evidente che viviamo in un'epoca «di bassa marea» (Cornélius Castoriadis), vale a dire in un'epoca in cui vi è molto da deplorare e poco per cui gioire. Non vi vedo tuttavia ragioni di disperare, o di rassegnarsi. Come ho già detto, la storia è fondamentalmente aperta. Nella vita degli uomini, allorché qualcosa ha termine, qualcos'altro si prepara a fare la sua apparizione. Non occorre dunque «sperare» quanto piuttosto rimanere attenti a ciò che sta per accadere. È sempre nel cuore della notte che appare la luce. Persino nell'oscurità più cupa si annuncia una nuova scintilla.
